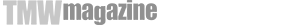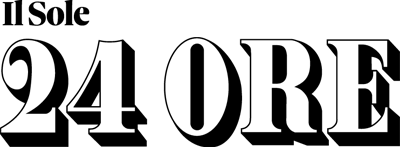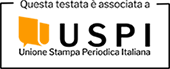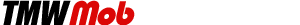Dario Dainelli: "Chiuderò la carriera al Chievo"
 TUTTO mercato WEB
TUTTO mercato WEBPer Pasolini è l'ultima rappresentazione sacra del nostro tempo, per Arrigo Sacchi l'unica cosa di cui ha parlato e continuerà a parlare, per Zeman è lo sport più popolare non grazie agli sponsor, ma al fatto che in ogni angolo del mondo c'è qualche bambino che si diverte con un pallone tra i piedi. Il calcio era ed è tutto questo e uno di quei bambini, tanti anni fa, era anche Dario Dainelli che dalle partitelle nei campini sfatti della Valdera è arrivato a giocare negli stadi più prestigiosi del calcio di serie A. Originario di Ghizzano, cresciuto nelle giovanili della Pecciolese Alta Valdera per poi passare in quelle dell'Empoli, a 19 anni è approdato a Modena, a 20 nel Fidelis Andria e a 22 ha esordito nel campionato di massima serie con il Lecce. Attuale difensore centrale del Chievo Verona, il calciatore pecciolese ha vestito le maglie dei club più storici d'Italia: Brescia negli ultimi anni di Baggio, Hellas Verona, Genoa e Fiorentina dove è stato il capitano per quattro stagioni. Una carriera calcistica lunga, per ora, tredici anni, che ha portato un ragazzino di provincia a toccare la Nazionale, restando sempre attaccato alla sua Toscana e realizzando il sogno di tanti di quei bambini negli angoli del mondo.
Partito da Peccioli, cresciuto e lanciato dall'Empoli, per giungere in alcuni dei club più prestigiosi d'Italia, toccando persino la Nazionale. Quanto è contato l'impegno e quanto la fortuna per arrivare dove sei?
"La fortuna è una componente, ma si parte sicuramente dalla predisposizione e dalle basi fisiche. Da bambini sono questi gli aspetti che si mettono più in evidenza, poi si cresce, arrivano le prime selezioni e le doti fisiche si assottigliano, il livello dei giocatori si alza, conta meno la prestanza fisica e più la volontà, il voler emergere, le motivazioni.
La fortuna nel calcio, a parte nei casi di infortuni vari che ti condizionano la vita, è molto relativa. Magari può influire sulla carriera: per fortuna, ad esempio, puoi arrivare in una squadra in un anno di successo piuttosto che in un anno poco felice, puoi trovarti meglio o peggio con lo staff, lo spogliatoio o la dirigenza. Ma non è possibile che, per sfortuna, si giochi in serie C e non in A".
C'è stato, durante la tua carriera, un momento o un periodo in cui hai realizzato che potevi davvero diventare un calciatore professionista?
"In realtà non c'ho mai riflettuto. Tutto si è realizzato salendo piccoli gradini, progressivamente. Nei settori giovanili, giochi e sei contento, ti basta questo. In Primavera o negli Allievi, cominci a fare le partitelle contro la Prima Squadra, ti misuri con i professionisti e quando magari ti accorgi di poter competere con loro e ricevere considerazione da parte dei giocatori più esperti e del mister, lì sì, ti senti più forte".
Nell'immaginario di molti, se non di tutti, la vita del calciatore è quella coronata solo di successi, notorietà e tanti soldi. È davvero tutto oro quel che riluce? Quali sono i risvolti negativi che sfuggono ai più?
"Non bisogna essere ipocriti. Già il fatto che un gioco che ti piace, quale in fondo è e dovrebbe essere il calcio, diventa il tuo lavoro, è un'immensa gratifica. Per questo noi calciatori siamo dei privilegiati. Il calcio a grandi livelli è capace di regale sensazioni forti che pochi altri mestieri ti danno. È anche vero però che sei continuamente sotto gli occhi di tutti, ogni domenica è un esame, durante il quale però non vieni giudicato solo da persone competenti in materia - "professori del calcio", se vogliamo proseguire nella metafora scolastica - ma anche da tante persone che sono semplicemente appassionate, tifosi. E questo genera una situazione di pressione che, se fai bene esalta al massimo le sensazioni positive, ma se fai male ti fa sentire tutto il peso del giudizio degli altri e cadere quasi in depressione. Il calcio, per chi lo gioca, è appassionante per questo: è capace di far provare emozioni contrarie in lassi di tempo brevissimi, è quello che nello spogliatoio prima di una gara importante ti fa dire "magari non ci fosse lo stress della partita", ma è anche quello che dopo il successo ti fa urlare "ma che bello è".
Uno dei più bei momenti o ricordi che il calcio professionistico ti ha regalato fino ad ora?
"Sono davvero tanti, non riesco a focalizzarne solo uno. Ovviamente penso ai momenti belli, quelli che hanno portato a un qualche successo. Un momento che non dimenticherò mai è di sicuro l'esordio in serie A con il Lecce, all'Olimpico contro la Roma del 2000-2001 che vinse lo scudetto, marcando Montella che in quella partita non segnò. Ma penso anche a Firenze e alla partita di Champions League con il Liverpool vinta due a zero, che ci permise di passare primi nel girone contro una squadra che fino a quel momento, per me e per tanti, era solo un mostro sacro visto tante volte in tv".
Per il pallone hai girato un po' tutta l'Italia, da Modena ad Andria, da Lecce a Brescia, fino a Firenze, Genova e Verona. Sei riuscito a mantenere un po' di "toscanità"?
"Il bello di essere toscani è che, dove vai vai, piaci a tutti! Quindi viene anche naturale mantenere invariato il modo di parlare, le abitudini, il legame con le mie zone. Nonostante abbia girato molte regioni da nord a sud, riesco ancora a dire "mi garba", forse anche perché ho giocato in Toscana fino a 18 anni e poi ho avuto la fortuna di tornarci più tardi stando a Firenze per ben cinque stagioni e mezzo".
Pontedera e Pisa l'ultimo anno calcistico hanno sognato la serie B, l'Empoli è tornato in A, il Livorno è retrocesso e la Fiorentina ti voleva a gennaio. Pensi di tornare a giocare a calcio in una squadra toscana o chiuderai la carriera a Verona?
"Ovvio che tornare a casa è un desiderio che sento, anche perché in Toscana ho la famiglia e gli amici. Al Chievo mi sono trovato molto bene e sarei fiero di chiudere lì la carriera. Se però il mio ultimo anno da calciatore sarà in una squadra toscana tanto meglio, altrimenti spero di poter tornare a casa per poter svolgere un lavoro sempre legato al mondo del calcio".